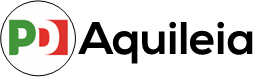Gregorio Bigattin (Bruno) di Aquileia ricorda 75 anni dopo la tragedia in cui morirono 95mila soldati italiani. È tra i pochissimi a poterlo ancora raccontare. Come Guido Coos di Tarcento: 1.100 chilometri a piedi a 45 gradi sotto zero
di Giacomina Pellizzari

«Mi sono salvato mangiando una tavola di legno. Me l’ero procurata perché un vecchio mi aveva detto: “Mastica il legno, ti dà saliva e vivi”». Gregorio Bigattin per tutti Bruno, è uno dei pochi reduci di Russia – in regione sono una cinquantina (gli iscritti alla sezione friulana dell’Unirr non sono più di sei) – ancora in grado di raccontare l’orrore vissuto dalle “centomila gavette di ghiaccio”. Oggi tocca a Bigattin e a Guido Coos di Tarcento ricordare anche se, alle volte, non vorrebbero doverlo fare: dalla fame, dal freddo e dalla morte che li accompagnarono per tutta la ritirata non si sono mai liberati.
Oltre 229 mila soldati furono sconfitti dal generale inverno prima che dai russi: indossavano gli stessi vestiti con i quali erano partiti nell’agosto precedente, il rancio era poco e le armi spuntate. In 95 mila non tornarono. Le stime dell’Unirr parlano di circa 70 mila prigionieri e di questi rientrarono poco più di 10 mila.
Gregorio Bigattin:
“Vi racconto la mia prigionia in Russia” Gregorio Bigattin, per tutti Bruno, è uno dei pochi reduci di Russia – in Friuli Venezia Giulia sono una cinquantina (gli iscritti alla sezione friulana dell’Unirr non sono più di sei) – ancora in grado di raccontare l’orrore vissuto dalle “centomila gavette di ghiaccio”. In quella tragica ritirata di Russia morirono circa 95 mila soldati (video a cura di Giacomina Pellizzari).
Nato il 9 maggio 1922, Bigattin non aveva ancora compiuto 20 anni quando venne arruolato al battaglione Gemona nell’8° reggimento Alpini della Julia con destinazione Plezzo. Era il terzo di tre fratelli e per questo aveva diritto all’esonero, ma lui preferì lasciare quella possibilità al fratello maggiore, già in Russia, che a casa aveva moglie e figli. Seguì qualche mese di addestramento, il trasferimento a Tarcento all’11° compagnia dell’artiglieria anticarro, prima di salire, era il 12 agosto 1942, sul treno che dalla stazione di San Giovanni al Natisone lo portò a Jzium, tra il Dnepr e il Don. Da qui iniziò la marcia verso Valujki e Rossos’. «Ho visto solo gente morire, niente altro».
La voce roca di Bigattin ti entra nell’anima: «Eravamo allo sbaraglio, senza vestiti, senza mangiare, con 45-47 gradi sotto lo zero. Nevicava, quanta neve, sotto ogni mucchio c’era un morto». Era una battaglia ad armi impari. «Prima di arrivare a Nikolajewka eravamo di qua e di là del Don. I russi cantavano la nostra canzone “Addio mia bella addio”». Fu una carneficina. Nella ritirata verso Valujki «sparavamo con pallottole perforanti “piccole” che nulla potevano fare».
I sopravvissuti imboccarono strade diverse, Bigattin, come molti altri, cercò aiuto nelle isbe dove i contadini russi dividevano con i militari sfiniti le razioni di patate. Arrivò a Nikolajewka. Il 24 gennaio 1943 attraversò la ferrovia salendo a tentoni, nonostante il congelamento alle gambe, sulla rupe da dove si lasciò rotolare. Si aggrappò a un carro di contadini e si ritrovò in ospedale con gli arti sempre più immobilizzati. «Era un congelamento di secondo grado, mi operarono strappandomi la pelle a freddo. Misi una suola in bocca e non riportai alcuna conseguenza».
Alcuni giorni dopo sgombrarono l’ospedale, Bigattin salì su un treno e 40 chilometri dopo venne fatto prigioniero. I russi gli sequestrarono il diario della ritirata, gli lasciarono solo il San Giuseppe che aveva ricevuto in dono da una donna prima della partenza. Da quel santino non si è più separato. Chiuso nell’Isba assieme ad altri 89 soldati, Bigattin rimase 17 giorni senza mangiare. Si salvò rosicchiando la tavola di legno. «Tutti i giorni moriva qualcuno e poi c’era il boia, era alto due metri, tutte le mattine veniva a controllare e guai se non trovava tutti al loro posto. Era un bestione sempre ubriaco, faceva paura». Bigattin capiva la loro lingua e una mattina ascoltò un russo mentre diceva a un tedesco “adesso ammazziamo gli italiani”. «Entrammo nella stanza in 90, ci fucilarono, uscimmo in 12. Mi salvai perché due soldati mi caddero addosso».
Da quell’ennesimo inferno lo liberarono le truppe tedesche. Bigattin salì su un treno diretto in Germania e poi sulla tradotta della Julia che lo portò a Vipiteno. Trascorse Pasqua 1943 in famiglia. Pesava 45 chili. E alla domanda «come si fa a vivere dopo un’esperienza del genere?», Bruno risponde: «Con fatica si tira avanti». E a chi gli fa notare che, 75 anni dopo, ci sono altri Paesi in guerra, lo sguardo del reduce di Russia si fa più intenso per aggiungere «non abbiamo capito niente»

Lo ripete anche Coos nella sua casa di Tarcento. Lo fa dall’alto dei suoi quasi 97 anni calandosi nei panni dell’alpino della Julia, battaglione Cividale sopravvissuto alla campagna di Grecia e alla ritirata della Russia. Coos si commuove, «mi fa male ricordare», rivela ammettendo di vivere tutti gli anni le giornate antecedenti le commemorazioni di Cargnacco con ansia. Con la mente torna all’agosto 1942, alla partenza verso il fronte ucraino, e rivede Vittorio Emanuele III al parco Moretti di Udine salutare gli alpini inviati al massacro.
«Il 4 gennaio 1943 occupammo la quota “Signal”, per la prima volta vidi la neve colorata di rosso con il sangue dei compagni colpiti dalle scariche delle mitraglie. Fu un combattimento cruento tant’è che il Comando tedesco chiamò quel cucuzzolo “Quota Cividale”». Ripiegarono il 16 gennaio, quel giorno iniziò la ritirata. «Percorremmo 1100 chilometri a piedi con più di 40 gradi sotto lo zero». Coos si accodò alla Tridentina che era più organizzata, anche lui, nelle isbe, venne aiutato dai contadini. «La gente non era contro», sottolinea spiegando che gli alpini erano partiti «per servire la Patria. Eravamo contro la guerra non per le idee politiche, bensì per le sofferenze a cui eravamo sottoposti».
Coos ha cercato di dimenticare ma questa impresa non gli è riuscita. «È impossibile farlo – ripete – la guerra è assurda». Perché «morire nella steppa significava perdere progressivamente conoscenza e aspettare che i 40 gradi di freddo avessero lentamente il sopravvento». Ogni volta che vedeva un corpo coperto dalla neve Coos pensava alla mamma di quel poveretto. Lo faceva perché non poteva dimenticare l’immagine di sua madre che, dopo aver salutato il figlio in partenza per la Russa, pensando di non essere vista, piangeva e malediva la guerra.
«Non pensate per noi, abbiamo forza e coraggio». Oppure: «Il mangiare non è tanto male, aspettavo il pacco con il tabacco». E ancora: «Mandami i guanti di lana e un po’ di filo che sono tutto strappato». Urano Lenisa, 8° reggimento alpini, battaglione Tolmezzo, di Preone, dalla ritirata di Russia non è più tornato. Le sue lettere sono state trovate pochi anni fa dal nipote Gildo, in una scatola conservata dalla nonna. «Le leggevo e piangevo», rivela la moglie di Gildo, Ingrid Franzolini, emozionandosi ancora mentre sfoglia la corrispondenza di guerra.
Quelle lettere brevi, scritte prima e dopo la battaglia di Nikolajewka, hanno incuriosito Matteo, il pronipote di Urano, che ha deciso di raccoglierle in una ricerca discussa alla scuola media Feruglio di Feletto Umberto.La tesina ha incuriosito anche Pierpaolo Lupieri, l’appassionato di storia contemporanea. È stato lui a convincere i familiari a rendere pubblici quei documenti, l’ha fatto per spiegare alle nuove generazioni l’assurdità della guerra.
«Ogni volta che le leggiamo, io e mio figlio, ci commuoviamo». Ingrid si cala nei panni della suocera, una delle tante, troppe mamme che persero i figli nella ritirata di Russia. «Urano carissimo da giorni non ho tue notizie – scriveva -, sono tanto in pensiero per te. Ti prego cerca di difenderti e di resistere a tutte le intemperie. Iddio ti aiuterà». E Urano sperava e, a sua volta, tranquillizzava la madre: «Non pensare ai debiti – scriveva nel 1942 – se Dio mi dà la grazia di tornare sano con il lavoro li pagherò».
Non è stato così, Urano dalla Russia non è più tornato. «Nei registri militari – continua la nipote – risulta morto il 21 gennaio 1943. L’ultima sua lettera risale al 28 dicembre 1942. La madre non si dava pace continuava a chiedere ai reduci del luogo notizie del figlio».Nelle lettere di Urano colpisce come i soldati partiti dallo stesso comune comunicassero tra loro. «Ho ricevuto una cartolina da Pietro, sta bene», scriveva. Oppure: «Ho trascorso il Natale con Ianich». Il 6 gennaio 1943, Lenisa era ancora vivo. Lo conferma la cartolina indirizzata alla madre da un compaesano, Firmino Pellizzari. Tutta la corrispondenza non era indenne alla censura. Colpiscono anche le raccomandazioni che venivano impartite sulla corrispondenza.
«Militari – si legge alla fine di qualche foglio – non riferite mai, a voce o per iscritto, nozioni che riguardano il vostro servizio. Tacete con tutti, anche con i vostri cari». Oppure in modo più diretto: «Sii sempre riservato su tutto ciò che riguarda il servizio».
Il grande inganno del duce alla gioventù italiana
l’intervento di ENRICO FOLISI
La vittoria degli alpini a Nikolajewka consentì ai sopravvissuti di svelare l’inganno della campagna di Russia agli italiani. Un inganno perpetrato dal duce del fascismo nei confronti dei propri giovani che aveva voluto a tutti i costi mandare in Russia insistendo con Hitler il quale volutamente l’aveva avvertito dell’attacco solo poche ore prima di sferrarlo, il 22 giugno 1941.
Mussolini voleva che l’esercito italiano ritornasse a combattere di nuovo una guerra parallela all’alleato tedesco e superasse quel ruolo da gregario che dopo la disastrosa campagna di Grecia era costretto a ricoprire. Quindi dichiarò guerra all’Unione Sovietica e inviò un Corpo di spedizione italiano in Russia, composto da 62.000 uomini, che iniziò le ostilità ad agosto. Nella primavera del 1942 il duce mandò un ulteriore corpo di spedizione l’Armir, con più di 200.000 uomini, di cui 57.000 erano truppe alpine, che partecipò all’avanzata in Ucraina, combattendo tra il Donec e il Don e riuscì a respingere un’offensiva russa alla fine di agosto, nonostante non avesse, né forze corazzate, né sufficienti automezzi e artiglieria anticarro e antiaerea, né attrezzature e vestiario adatto al freddo siderale dell’inverno russo. Il 19 novembre 1942 i sovietici sferrarono una decisiva nuova offensiva che travolse le armate dell’Asse a Stalingrado, sul Don, ovunque.
Tutte le forze italo tedesche iniziarono ad arretrare e anche l’Armir dovette affrontare una disastrosa ritirata, a piedi in pieno inverno alla mercé dei continui attacchi dei russi che riuscirono a chiuderla in una sacca. Gli italiani subirono più di 25 attacchi prima di Nikolajewka, la battaglia che riuscì a rompere l’accerchiamento e a far sì che i superstiti si potessero salvare.
La drammatica cronaca della battaglia l’abbiamo grazie alla testimonianza, pubblicata dall’editore Gaspari, di Diotalevio Leonelli, alpino artigliere, aggregato alla Julia
«Era il 26 gennaio, martedì, e splendeva il sole. Eravamo una colonna interminabile di uomini, probabilmente sui diecimila soldati, distesa per chilometri sul dosso da cui si scendeva per Nikolajewka. C’era un trambusto che non si capiva niente. Spari da una parte, spari dall’altra. Noi della Julia eravamo decimati e disarmati. Soltanto la Tridentina, pur essendo fortemente decimata, avendo fatto un percorso più breve di noi nella ritirata, (era di stanza più a nord), aveva ancora un discreto contingente di forze e armi ed aveva ancora il suo comandante, il generale Luigi Reverberi. Fra noi si diceva che Nikolajewka era l’unico punto dove si potesse rompere l’accerchiamento. Arrivammo sulla collina poche ore prima dell’attacco. Il generale Reverberi sapeva che se non fossero riusciti a sfondare prima della notte, sarebbe stata la fine. Davanti a noi c’era la ferrovia con un sottopassaggio. I russi erano già appostati e nascosti lungo il costone della ferrovia ed aspettavano che noi agissimo. Il generale Reverberi ad un certo punto salì su un carro armato ed urlò: All’urlo del generale si unirono le urla di tutti gli alpini che si lanciarono verso la ferrovia. Noi ci buttammo al seguito della Tridentina. A guardarci dal basso della collina dovevamo apparire una massa spaventosa. Migliaia di uomini scatenati resi folli dalla disperazione. Al momento della reazione russa scoppiò l’inferno. I russi cominciarono a sparare su di noi: era tutto un fuoco incrociato, da una parte e dall’altra. Come se non bastasse, due aerei russi facevano la spola, alternativamente, spezzonando e mitragliando su di noi truppe italiane, facendo una vera carneficina. Subimmo fortissime perdite umane. Nella serata si aprì un varco fra le linee russe, grazie alla disperata lotta degli alpini per sfuggire all’accerchiamento nemico. Noi pochi sopravvissuti di quella tremenda battaglia scendemmo per una scarpata, camminando sopra i corpi dei nostri commilitoni e riuscimmo ad arrivare al sottopassaggio della ferrovia ed uscire dalla sacca. Non ci fermammo a Nikolajewka. Nonostante la fatica e le condizioni precarie preferimmo continuare a camminare tutta la notte per allontanarci il più possibile dal fronte russo. Eravamo usciti dalla sacca. Sapevamo di avere fatto un passo fondamentale verso la Salvezza».
Durante il ripiegamento morirono congelati, furono uccisi e caddero prigionieri decine di migliaia di giovani italiani. I tedeschi su autocarri o su treni schernivano e deridevano gli italiani che si trascinavano spesso senza scarpe con i piedi avvolti in pezze e quando cercavano di salire sugli autocarri, venivano colpiti col calcio dei fucili. Il crudo racconto dei superstiti, una volta in Italia, fu la condanna dell’assurda politica di guerra del fascismo, degli alleati tedeschi che si erano comportati peggio dei nemici. Le popolazioni delle valli alpine che avevano ascoltato il racconto dei superstiti sulla sorte dei loro figli e fratelli, degli amici che erano morti o scomparsi in Russia e gli stessi reduci, di lì a poco, si schiereranno con la resistenza contro il nazifascismo.La vittoria di NiKolajewka fu la sconfitta di Mussolini e dell’intera gestione politica, militare e amministrativa, della classe dirigente chiamata a tutti i livelli a compiacere e a rendersi complice della scelta insensata dell’alleanza con la Germania nazista e della guerra.
20 gennaio 2018
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine