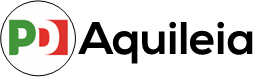L’analisi dei flussi elettorali dem dimostra che non c’è stato un tracollo. Ma la classe dirigente è incapace di leggere i messaggi della società civile
di Simone Bressan

UDINE. I video online che insegnano ai principianti a giocare a scacchi spiegano con dovizia di particolari come sia impossibile fare “scacco matto” in tre mosse in assenza di gravi errori da parte dell’avversario.
La dirigenza del Pd regionale probabilmente si starà chiedendo quali errori ha compiuto se è vero che in tre tornate elettorali in meno di sette mesi i dem sono passati dal governare Trieste, Pordenone e Monfalcone, avendo messo nel mirino la conquista di Codroipo, a un secco quattro a zero a favore degli avversari.
Con il sigillo del referendum costituzionale di domenica scorsa.
Il rapporto tra governo e territorio ha iniziato a scricchiolare pesantemente con le sconfitte di Roberto Cosolini e Daniela Giust, in quelle che avevano tutto il sapore di elezioni di medio termine per la maggioranza regionale.
I problemi si sono acuiti con il tentativo fallito di riconquistare Codroipo e con la sanguinosa sconfitta di Monfalcone. Se nel primo caso è giusto guardare più ai meriti di Fabio Marchetti che ai demeriti del centrosinistra, nel Comune sede di Fincantieri e storica roccaforte democratica si è consumato un vero e proprio divorzio tra base progressista e classe dirigente.
Ai due campanelli di allarme è seguito il rintocco del referendum di domenica scorsa con il No che vince praticamente ovunque: nelle città e in provincia, nei Comuni dove si è appena votato e in quelli dove si voterà a breve, nelle “zone rosse” e nei “feudi azzurri”.
In tutti questi tre appuntamenti elettorali si è espresso, consapevolmente o meno, un giudizio su piazza Unità. Quando si è votato per il rinnovo dei municipi, le riforme regionali di enti locali e sanità sono state al centro del dibattito politico.
Mentre nel caso del voto sulla riforma costituzionale, in prima fila c’era direttamente Debora Serracchiani, come governatrice schierata per il Sì ma anche e soprattutto come vicesegretario del Pd.
A difesa della presidente c’è da dire che in tutto il mondo, dalla Brexit a Trump fino alla Francia, sembra esserci un unico pattern per leggere in controluce i risultati elettorali: il rifiuto netto e senza appello delle politiche nazionali e di chi in quel preciso istante è identificato come establishment. Indipendentemente dal merito.
Ritornando al risultato di domenica, attribuire la sconfitta della linea renziana all’attuale governatrice impone, per coerenza, di assegnarle il merito del 39% raccolto in regione dal fronte del Sì. Questo apre un tema di discussione non banale: la cifra coincide esattamente con quella che Serracchiani raccolse alle elezioni regionali del 2013.
Non è del tutto vero, quindi, che il centrosinistra regionale crolla: bisogna, piuttosto, ragionare sul fatto che alla governatrice non sia riuscita l’operazione politica di trasformare una vittoria di “minoranza” in una piattaforma politica in grado di convincere la metà più uno dell’elettorato regionale e di ricomporre, almeno in parte, la frattura che si è creata nel 2013 con la spaccatura del consenso in tre tronconi (centrodestra, centrosinistra e grillini).
Il dato numerico offre poi un altro spunto di riflessione: il Sì domenica ha raccolto 267 mila voti. Serracchiani vinse le regionali con 211 mila preferenze e alle elezioni europee il fronte di Governo (Pd e Ncd) mise insieme 265 mila voti.
Non c’è stato, insomma, nessun terremoto dal punto di vista numerico anche se appare evidente come la lettura politica segni una direzione ben precisa e la percezione è quella di una leadership regionale non più così forte e di un centrosinistra in netta difficoltà.
Oggi, Serracchiani e i dem, sono davanti a un bivio molto chiaro. Per uscire dallo stallo e invertire la parabola discendente devono operare una scelta che per forza di cose non sarà neutra rispetto alla comunità politica di riferimento.
Il Pd può ragionevolmente partire da quei 267 mila voti a favore della riforma costituzionale e provare a costruire “al centro” dello schieramento politico, replicando l’assetto dell’attuale maggioranza e quello della probabile coalizione che si presenterà al prossimo voto per Camera e Senato.
Una specie di “Partito della Regione”, con il Pd in posizione baricentrica e una coalizione aperta ad aggregare chi ha sostenuto la riforma renziana, a partire dai pezzi importanti dell’imprenditoria e della società civile per finire con i centristi di Area Popolare.
Un’opzione che sconterebbe, con ogni evidenza, il limite di tagliare definitivamente fuori dal perimetro progressista una fetta consistente della cultura autonomista regionale.
La seconda strada è un ritorno, magari con qualche accorgimento, alle origini del centrosinistra. A quello che a livello nazionale viene definito “modello Ulivo” e che potrebbe ricalcare i confini di “Intesa Democratica”, la coalizione che portò Riccardo Illy a piazza Unità nel 2003.
In questo secondo scenario il Pd regionale dovrebbe riavvolgere le lancette all’indietro, rinnegando l’esperienza renziana superando a sinistra il Governo nazionale.
Quella coalizione seppe, grazie anche al profilo di chi la guidava, tenere insieme uno spettro molto ampio: dagli ex democristiani alla sinistra radicale, dialogando con l’autonomista Cecotti a Udine e, contemporaneamente, con Cgil e Confindustria. Rintanarsi nel business as usual, sperando passi la nottata, è l’unica cosa che non può permettersi.
Perché aumenterebbe la sensazione di una classe dirigente incapace di leggere i messaggi che le arrivano da un elettorato sempre più reattivo e sempre più esigente. E per questo sempre meno disposto ad accettare l’immobilismo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
07 dicembre 2016
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine